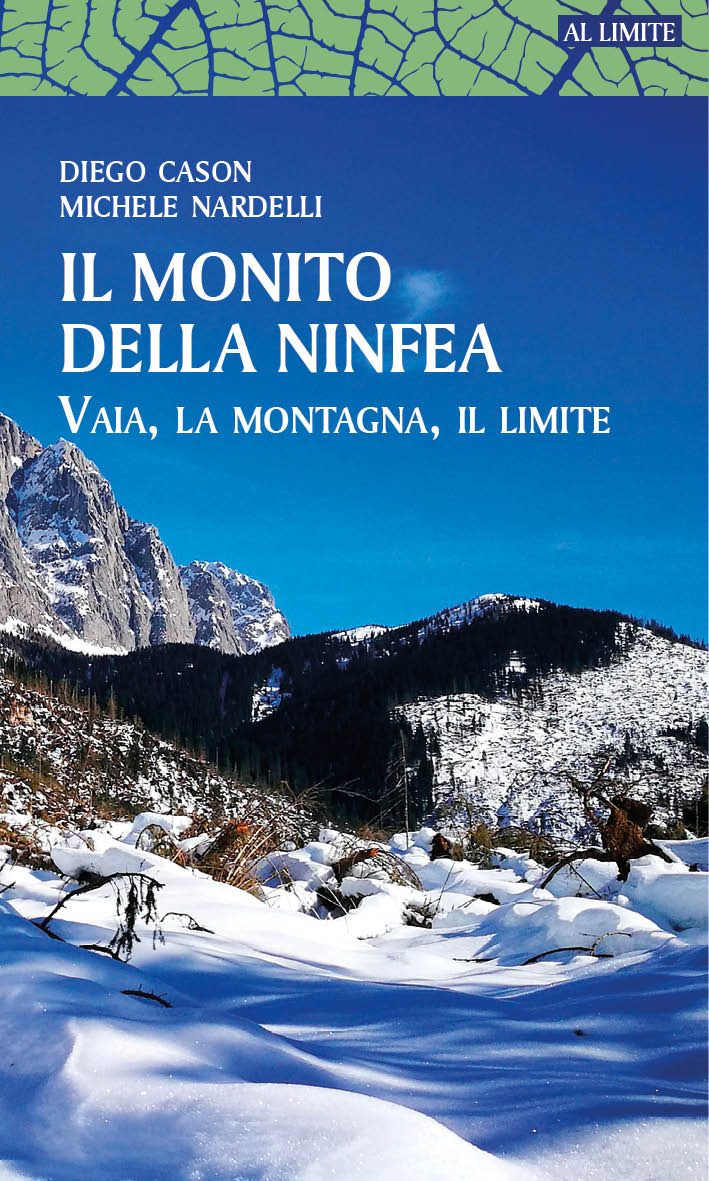
La metafora del nostro tempo
19 Maggio 2021
La sfida di un destino comune
1 Giugno 2021Non sono solo i racconti dei nostri padri. Secondo i nuovi storici israeliani, dietro lo svuotamento di ogni villaggio o città palestinese ci fu un massacro. Sono i documenti israeliani che, finalmente, irrompono nella storia ufficiale, sbugiardando quella fornita dallo Stato di Israele attraverso un imponente sistema di propaganda diffusa in tutto il mondo. Tanto che per anni la discussione è stata ridotta allo stabilire se la Palestina esistesse o non esistesse.
E, ancora oggi, il cuore del problema sta nel fatto che la Palestina non c’è se non come un ricordo o come un’idea, o più semplicemente come un atto di affermazione della volontà di un popolo. Un problema come tanti che corrisponde al fatto che lo status del soggetto al quale ci riferiamo è incerto, instabile e da definire, come affermava Edward Said. Una controversia, insomma, tra affermazione e negazione.
Qualcuno potrebbe dirmi che ormai la catastrofe appartiene al passato, che Israele è uno Stato riconosciuto dalla Nazioni Unite, che in quella terra vive un altro popolo e bisogna guardare al futuro.
Ci abbiamo anche creduto alla necessità di guardare al futuro, insieme a una buona parte dei palestinesi, con gli accordi di Oslo del 1993. Volevamo aprire una pagina nuova e pensare ad un futuro di cooperazione, rinunciando all’82% del territorio storico della Palestina e mettendoci in gioco nel cercare di comprendere la narrazione israeliana.
Malgrado tutto questo, vent’anni dopo quegli accordi la catastrofe sembra non avere mai fine, continuano le confische della terra, la colonizzazione ebraica del territorio dove – secondo gli Accordi – avrebbe dovuto sorgere lo Stato palestinese, le incursioni armate dei coloni ebrei nei villaggi palestinesi, la distruzione delle case e l’incendio dei campi, il furto dell’acqua. Così come prosegue la discriminazione razziale dei cittadini palestinesi che vivono in Israele e l’assedio di Gaza, ormai una prigione a cielo aperto. Pensando all’idea sionista di dar vita ad uno Stato etico degli ebrei, forse non poteva che andare così.
«Perché gli arabi dovrebbero fare la pace? Se fossi un dirigente arabo non fermerei mai (la pace) con Israele. E’ normale: abbiamo preso il loro paese. Certo, Dio ce lo ha promesso, ma in cosa li può interessare ciò? Il nostro Dio non è il loro. E’ vero che siamo originari di Israele ma questo risale a duemila anni fa: in che cosa li riguarda? C’è stato l’antisemitismo, il nazismo, Hitler, Auschwitz. Ma è stata colpa loro? Loro vedono una cosa: siamo venuti e abbiamo rubato il loro paese. Perché dovrebbero accettare questo fatto?».
Sono le parole di David Ben Gurion, il fondatore dello Stato di Israele e il suo primo capo di governo che esprimeva anche la sua ripugnanza di fronte al diffuso saccheggio e agli atti vandalici operati dai esponenti e personalità di spicco della sua gente.
Non si tratta “solo” di una violazione del diritto internazionale: quella violazione è diventata l’esercizio di una falsa coscienza, una menzogna trasmessa a se stessi ed agli altri. Rappresenta la scelta di trasgredire la legge dell’anima. L’eterna questione del bene e del male o, se volete, la banalità del male. Eppure, quando nel 1897 il primo congresso sionista decise di costituire uno stato nazionale in Palestina come risposta alle persecuzioni subite in Europa, il capo della commissione inviata per esplorare la Palestina mandò un telegramma dicendo che il territorio è bellissimo ma è abitato da un altro popolo.
Quando si accetta di mentire a se stessi, poi si ricorre a tutte le categorie filosofiche per autogiustificarsi. Palestina terra senza popolo e gli ebrei un popolo senza terra. Dare una patria al popolo ebraico vittima dell’Olocausto, sviluppare e portare progresso alla regione. Gli ebrei non hanno nessun posto dove andare mentre i palestinesi sono arabi e possono andare in quei paesi… . E poi essere portatori di un modello collettivo (quello dei Kibbuz), tanto da rendere irrilevante la sorte degli abitanti originali di quelle terre costretti a marcire in qualche campo profughi. Utilitarismo morale.
La morale corrente diviene la legge del più forte e il riferimento è ad un compito storico che può giustificare nel suo cammino ogni sopruso. Eppure la tragedia del Terzo Reich avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. Quello stesso compito storico evocato nell’“infinita guerra” contro l’Iraq, in Afghanistan o in Siria, ovviamente in nome della democrazia e dei diritti umani. Anche un tempo alle operazioni di pulizia etnica si dava un nome in codice, nel 1948 in Palestina era “Scopa”, nel 1982 in Libano era “Pace in Galilea”.
Sono uomini che emergono dal fondo senza fondo. Non hanno limiti e c’è sempre una giustificazione per i propri assunti. Malati di ipertrofia della (falsa) coscienza. Tanto che, di fronte all’evidenza, trovano una auto-giustificazione per andare oltre l’evidenza. Diventano loro stessi nel buco dove vivono e tramano, fondatori di valori basati sul nulla. Siamo nel pieno del nichilismo.
Dramma nel dramma, c’è un effetto trascinamento che accomuna le parti verso il fondo. Perché se il paradigma è lo stesso, se si continua a considerare la violenza come levatrice della storia, se si pensa alla pace come l’esito della guerra, se il progresso è il dominio delle cose sull’uomo, se lo Stato-Nazione con i suoi rituali identitari non si mette in discussione nemmeno in un contesto dove è la realtà ad essere sovranazionale ed interdipendente, il futuro non ci riserverà niente di nuovo. Lo dico come palestinese ma anche come italiano.
Chiedere che le Nazioni Unite impongano di mettere fine al massacro è il minimo. Ma se non vogliamo che il passato continui ad incombere sul presente e sul futuro occorre cambiare l’approccio alla questione, anche in maniera unilaterale. A cominciare dall’immaginare un unico paese dal Giordano al Mediterraneo fondato sullo “stato di diritto”, dove cioè si è cittadini non in base alla propria nazionalità, al proprio credo religioso o alle proprie idee, ma in quanto persone.
Non facciamoci trascinare nel fondo, nel buio dove rimuginiamo la nostra sconfitta e il nostro dolore. Non diamola vinta al rancore che ci avvelena e che ci fa diventare a nostra volta oltre che vittime anche carnefici.
Come scrive il poeta Mahmud Darwish, «Noi viviamo di parole. Dunque anche tu parla, perché io possa vivere».
* già viceambasciatore palestinese in Italia

